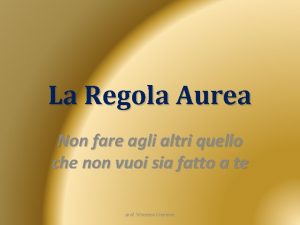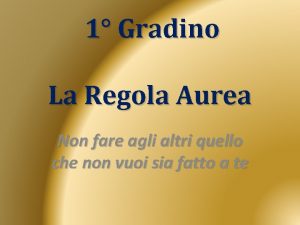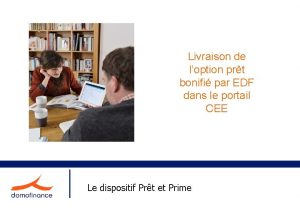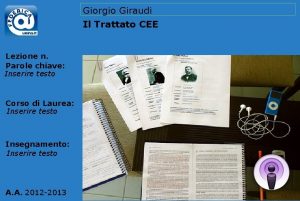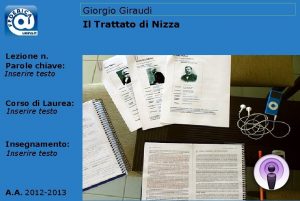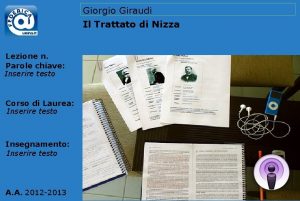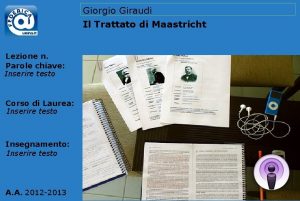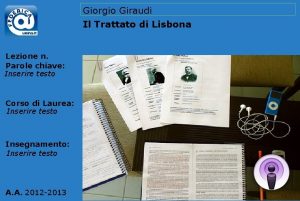Giorgio Giraudi Il Trattato CEE Lezione n Parole







- Slides: 7

Giorgio Giraudi Il Trattato CEE Lezione n. Parole chiave: Inserire testo Corso di Laurea: Inserire testo Insegnamento: Inserire testo A. A. 2012 -2013

Il sistema istituzionale Firmato a Roma nel marzo del 1957, il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (cd. Trattato di Roma) è ancora oggi la base del processo di integrazione europea. Esso era uno strumento che era stato pensato principalmente in funzione della costruzione di un mercato unico, tuttavia presentava anche finalità, strumenti e elementi propri dell'integrazione politica. Infatti nel Preambolo del Trattato esso veniva presentato come uno strumento utile al fine di conseguire '(…) un'unione sempre più stretta tra i popoli europei', (…) 'il costante miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione degli stessi popoli' (…) 'uno sviluppo armonioso delle economie degli stati membri riducendo le disparità tra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite' (…) 'la difesa della pace e della libertà'. Già con il solo riferimento al Preambolo si capisce quindi che il processo di integrazione nasce come un progetto aperto senza una finalità unica definita una volta per tutte; esso è un progetto politico e istituzionale che vede fin dall'inizio la compresenza di diversi attori: gli stati nazionali con i loro governi, le istituzioni comunitarie, gli attori economici pubblici e privati, i popoli europei, i territori dell'Europa. Il 25 marzo 1957, verso le ore 18. 00, in Campidoglio a Roma, nella sala degli Orazi e Curiazi, vennero firmati i Trattati costitutivi rispettivamente della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom).

Il mercato unico I pilastri del nascente mercato comune erano stati individuati in quattro libertà fondamentali: 1) libera circolazione delle merci; 2) libera circolazione dei capitali; 3) libera circolazione delle persone (inizialmente dei lavoratori); 4) libera circolazione dei servizi. Per costruire il mercato comune il Trattato prevedeva una strategia graduale che individuava nella creazione di un'Unione doganale europea il primo e fondamentale passo da compiere. All'eliminazione delle barriere tariffarie interne e all'adozione di una tariffa doganale esterna comune si affiancavano delle politiche pubbliche necessarie ad evitare che il Trattato desse vita solamente a una zona di libero scambio invece che a un vero e proprio mercato comune. Lo stesso Trattato conteneva quindi disposizioni relative alla tutela e promozione di tutte e quattro le libertà fondamentali e alla creazione di una politica della concorrenza gestita autonomamente dalla Commissione europea, ma anche norme relative alla politica commerciale comune, alla bilancia dei pagamenti, ai trasporti, alcune disposizioni fiscali e anche (poche) disposizioni in materia di politiche sociali.

L’architettura istituzionale (1) Il disegno istituzionale previsto nel Trattato CEE ricalcava per sommi capi quello già ideato e sperimentato nella CECA (vedi prima lezione). Le istituzioni comunitarie erano quattro: • la Commissione, • il Consiglio, • l'Assemblea • la Corte di giustizia. Lo schema concettuale complessivo era quello funzionalista/realista di Jean Monnet: ricreare a livello sovranazionale una struttura istituzionale che presentasse tutti gli elementi chiave dell'ordine politico statale, cioè l'expertise tecnico, il governo, la rappresentanza politica e la rule of law. La Commissione era una struttura tecnocratica sopranazionale formata da un corpo amministrativo guidato da esperti di policy nominati dai governi degli stati membri ma non dipendenti da essi. Essa doveva rappresentare innanzitutto il motore dell'integrazione promuovendo gli interessi comunitari e facilitando i necessari accordi e convergenze tra gli stati membri. A questa funzione di 'imprenditore di policy' se ne affiancava una di 'guardiano dei Trattati' da esplicare secondo due modalità; o gestendo direttamente politiche cruciali e altamente sensibili come la politica della concorrenza o esercitando una funzione più generale di controllo del rispetto degli obblighi giuridici derivanti dal diritto comunitario attraverso l'attivazione di una 'procedura di infrazione'.

L’architettura istituzionale (2) In concordanza con lo schema funzionalista di Monnet, il Trattato CEE prevedeva l'istituzione di una Assemblea rappresentativa. L'Assemblea, costituita inizialmente da 144 parlamentari nazionali provenienti da sei stati membri, era stata pensata inizialmente come una istituzione di controllo (soprattutto del bilancio) e non come una istituzione che godesse del potere legislativo. Essa forniva al Consiglio pareri obbligatori ma non vincolanti sulle proposte presentate dalla Commissione allo stesso Consiglio. Era invece nei confronti della Commissione che l'Assemblea poteva esercitare un controllo più penetrante, poiché il Trattato prevedeva che potessero essere svolte interrogazioni orali o scritte sull'azione svolta dalla Commissione. Inoltre l'Assemblea valutava una volta l'anno la relazione annuale sull'attività svolta prodotta dalla Commissione, decideva il discarico o meno delle spese sostenute dalla stessa Commissione e, in caso di colpe o manchevolezze gravi nella gestione, poteva approvare una mozione di censura nei confronti della Commissione in carica costringendola alle dimissioni di massa. Riunione dell'Assemblea Parlamentare Europea, 12 ottobre 1959, Archivio Storico della Camera dei deputati

L’architettura istituzionale (3) All'azione della Commissione si affiancava quella legislativa del Consiglio, cioè dell'istituzione all'interno della quale dovevano trovare spazio e composizione le posizioni espresse dai governi nazionali. A questo scopo la composizione del Consiglio era riservata ad alti rappresentanti degli stati membri (normalmente ministri nazionali). Poiché era prevalsa un'idea funzionale del processo di integrazione articolata sugli ambiti di policy, il Trattato prevedeva che il Consiglio si riunisse con una composizione settoriale limitata ai ministri competenti per materia. Ad ogni stato era stato attribuito un pacchetto di voti rozzamente proporzionale alla dimensione della popolazione presente in ogni singolo stato. La regola decisionale inizialmente adottata sarebbe stata l'unanimità. Tuttavia lo stesso Trattato prevedeva che dopo dieci anni il Consiglio avrebbe deciso in base alla regola della maggioranza qualificata dei due terzi. Il Consiglio Affari Generali, composto dai ministri degli Esteri, svolgeva una funzione di coordinamento generale, tuttavia nel Trattato CEE non era previsto nessun direttorio politico stabile formato da capi di stato o di governo.

L’architettura istituzionale (5) Il Trattato CEE affidava il controllo di legalità degli atti prodotti e il controllo del rispetto degli obblighi prodotti dal diritto comunitario ad una apposita Corte di giustizia. La creazione di questa istituzione assicurava la prevalenza del principio della rule of law e assicurava una interpretazione uniforme del diritto comunitario in tutti i territori della CE. Essa era stata voluta dagli stati più piccoli per evitare che i grandi stati egemonizzassero il processo decisionale o si sottraessero agli obblighi comunitari. La Corte era composta da sette giudici nazionali proposti dai governi degli stati membri nominati per un mandato di sei anni rinnovabile. Tra le varie disposizioni del Trattato CEE, spiccava la presenza di un meccanismo di raccordo tra giudici nazionali e Corte di giustizia comunitaria che prevedeva che, nei casi nei quali si presentavano profili di diritto comunitario, i giudici nazionali potessero richiedere alla Corte di giustizia un parere pregiudiziale chiarisse il contenuto della norma comunitaria e il rapporto con le norme nazionali nel caso in questione (c. d. rinvio pregiudiziale). Insediamento della Corte di Giustizia, 7 ottobre 1958; Fonte: http: //curia. europa. eu