Platone Lettera VII Perch non questa mia una
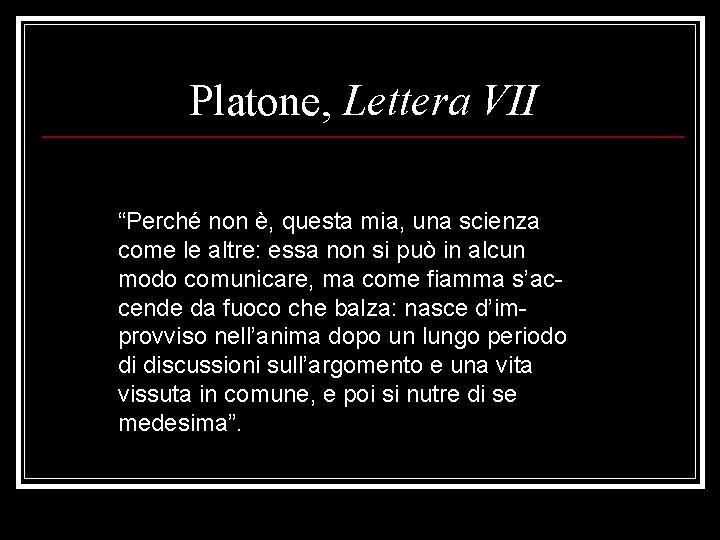
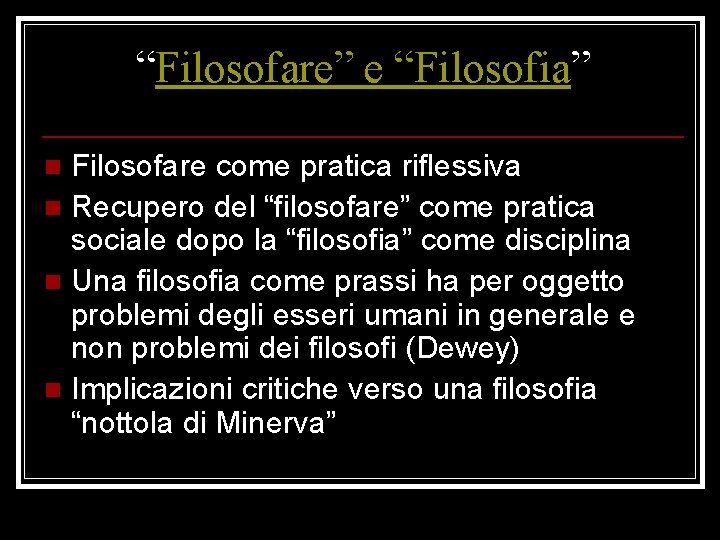

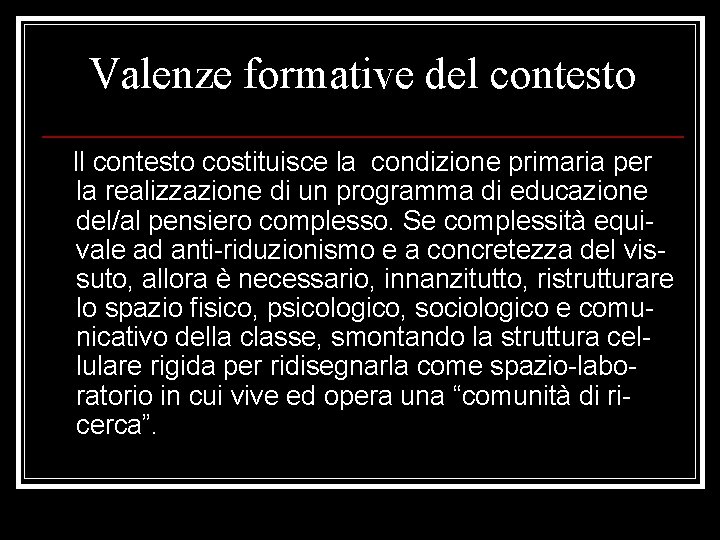
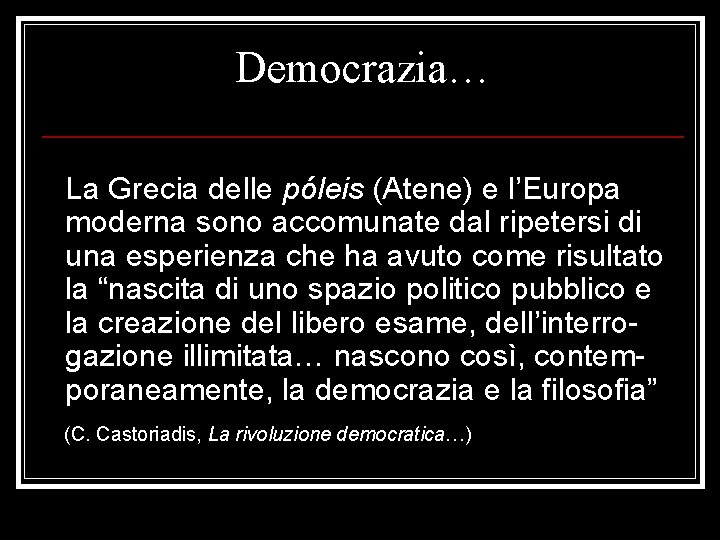
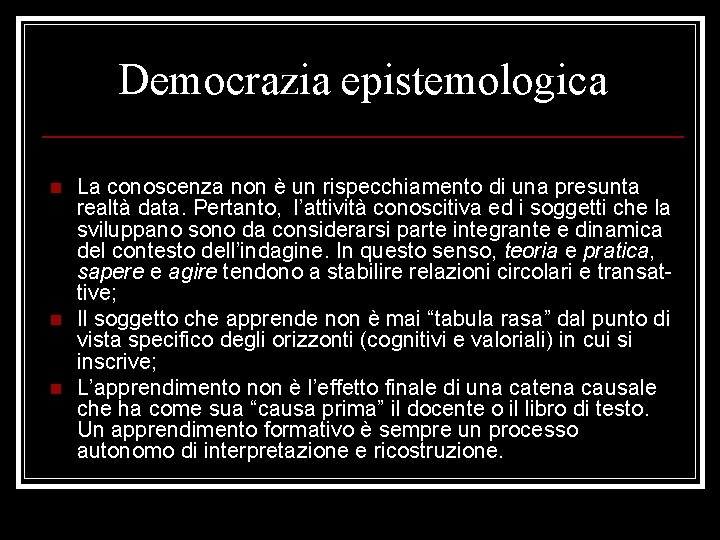
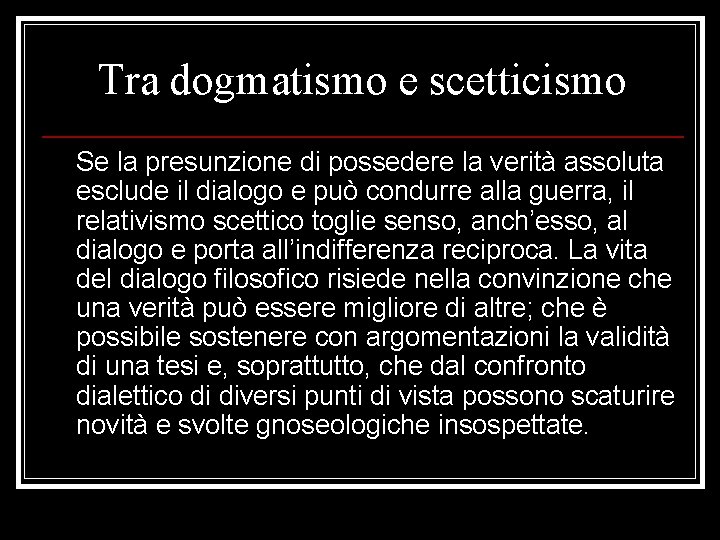

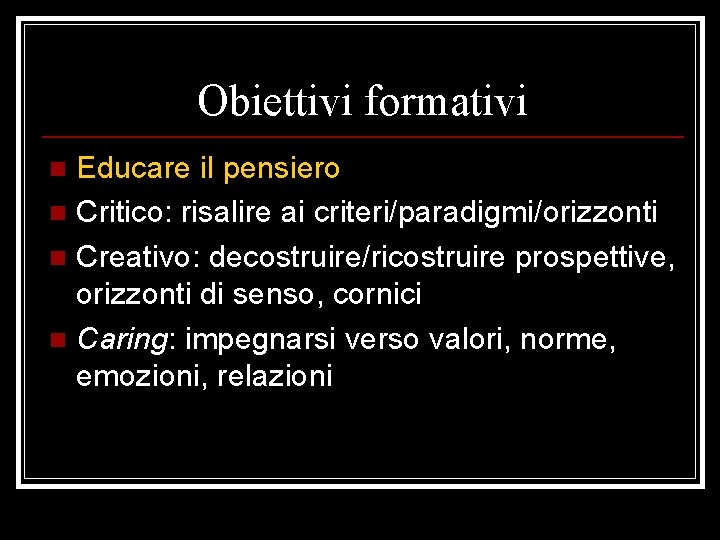
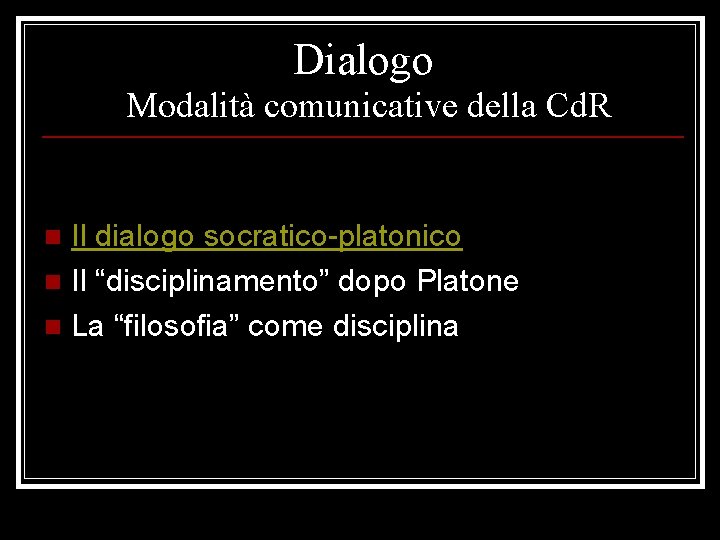
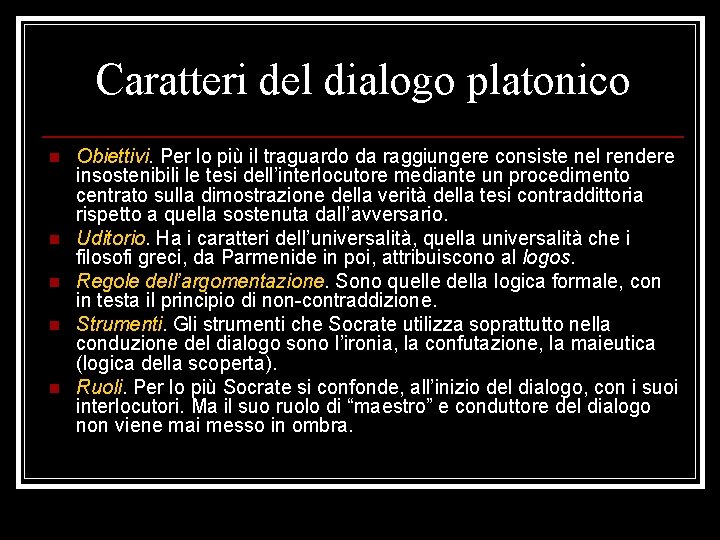
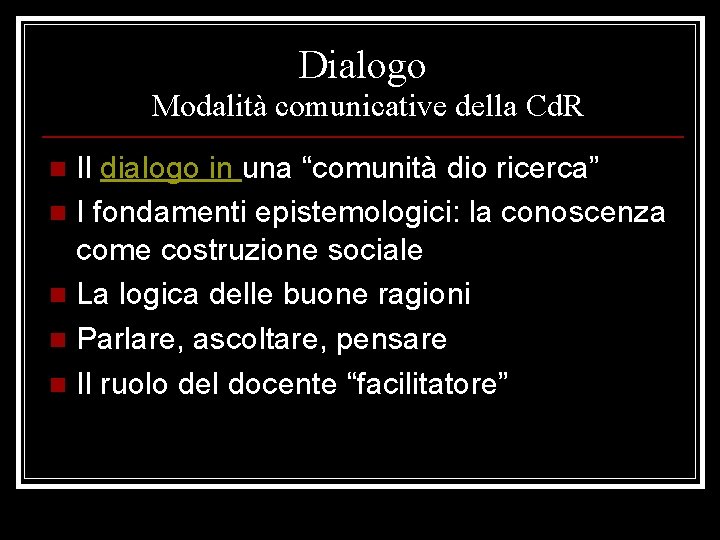

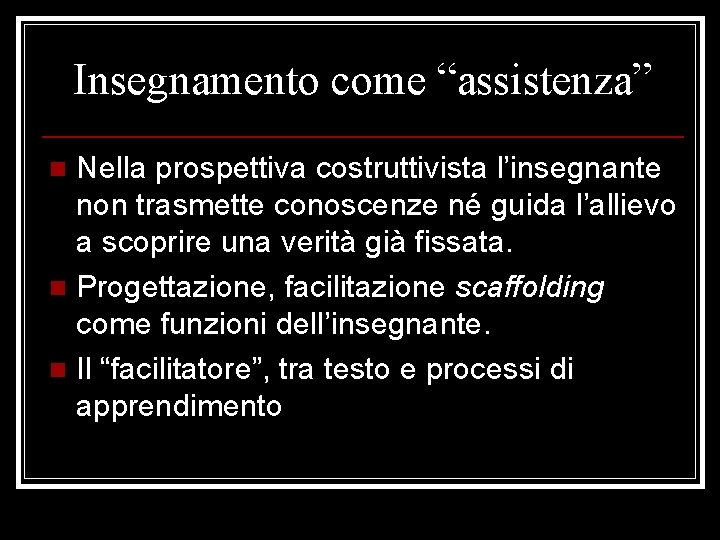
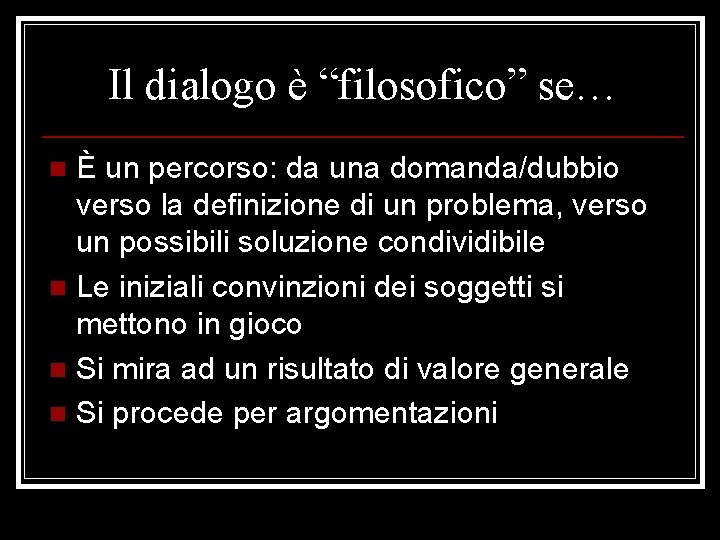
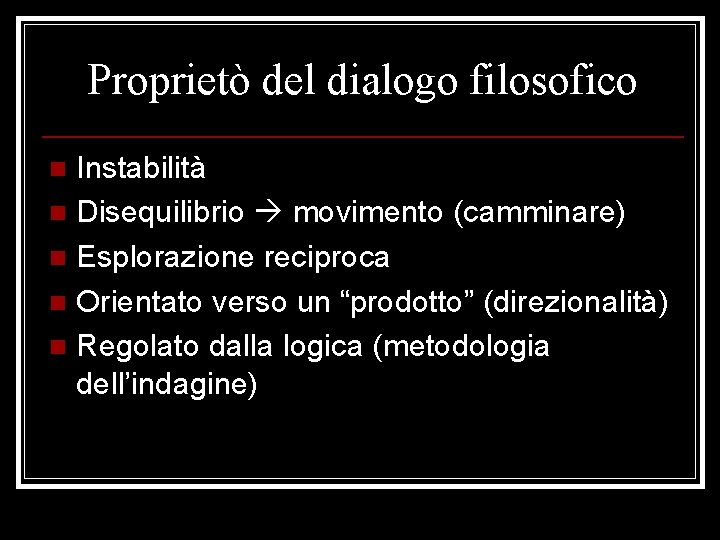
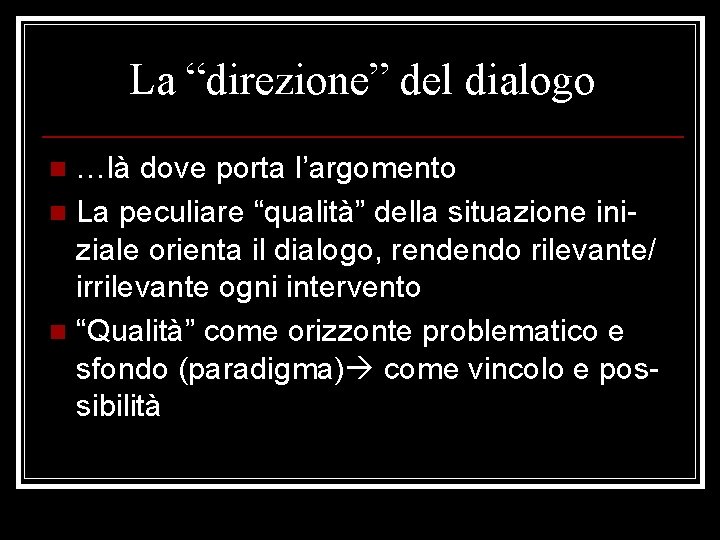
- Slides: 17
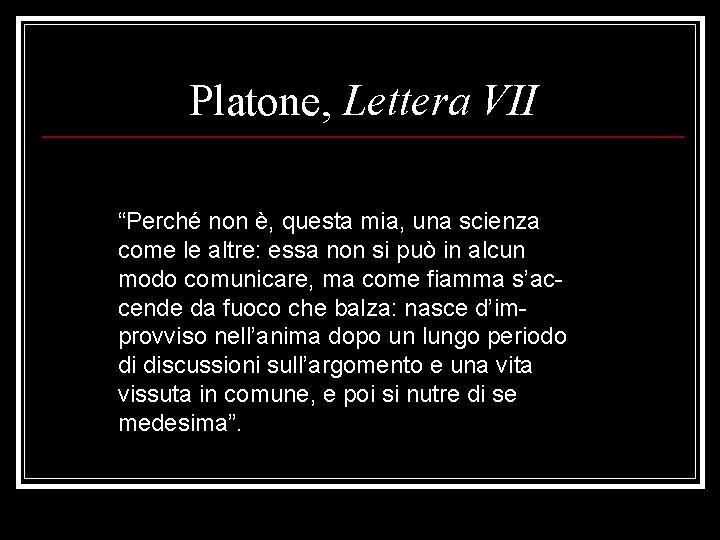
Platone, Lettera VII “Perché non è, questa mia, una scienza come le altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima”.
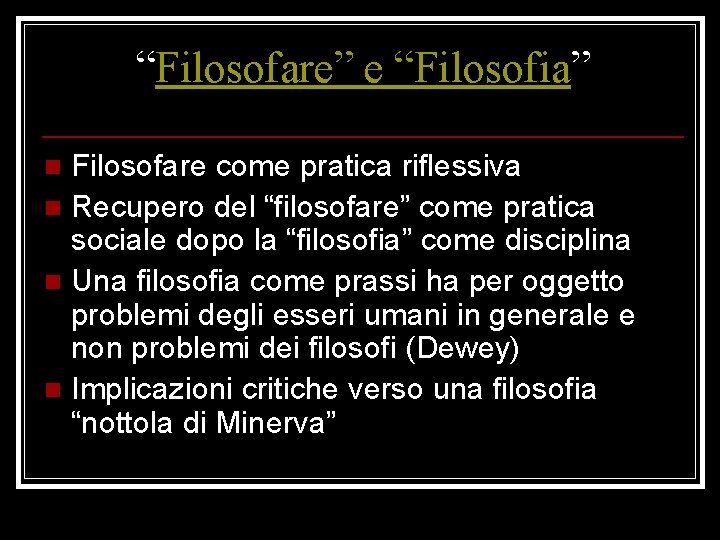
“Filosofare” e “Filosofia” Filosofare come pratica riflessiva n Recupero del “filosofare” come pratica sociale dopo la “filosofia” come disciplina n Una filosofia come prassi ha per oggetto problemi degli esseri umani in generale e non problemi dei filosofi (Dewey) n Implicazioni critiche verso una filosofia “nottola di Minerva” n

La “Comunità di ricerca” “Comunità” come contesto (relazionale, emozionale, etico-politico) n “Ricerca” come processo di riflessione regolata e mirata n Democraticità epistemologica e politica n
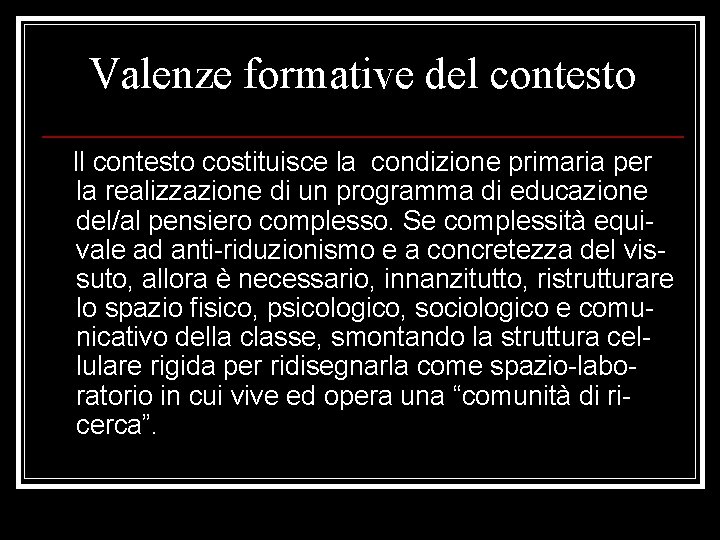
Valenze formative del contesto Il contesto costituisce la condizione primaria per la realizzazione di un programma di educazione del/al pensiero complesso. Se complessità equivale ad anti-riduzionismo e a concretezza del vissuto, allora è necessario, innanzitutto, ristrutturare lo spazio fisico, psicologico, sociologico e comunicativo della classe, smontando la struttura cellulare rigida per ridisegnarla come spazio-laboratorio in cui vive ed opera una “comunità di ricerca”.
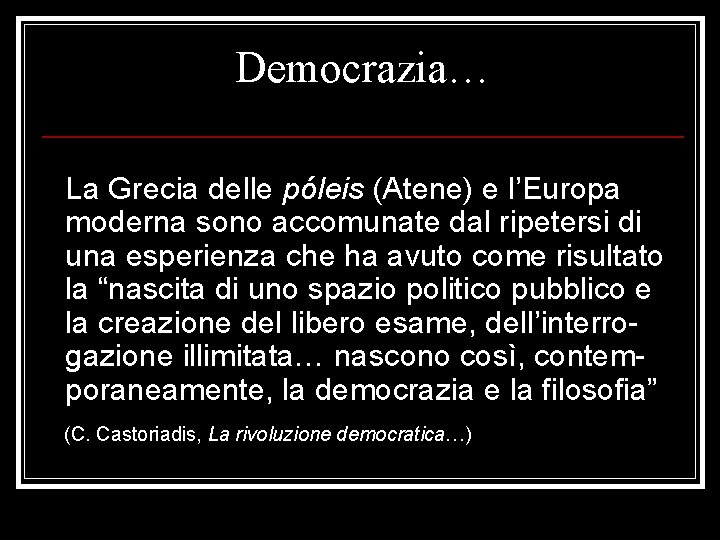
Democrazia… La Grecia delle póleis (Atene) e l’Europa moderna sono accomunate dal ripetersi di una esperienza che ha avuto come risultato la “nascita di uno spazio politico pubblico e la creazione del libero esame, dell’interrogazione illimitata… nascono così, contemporaneamente, la democrazia e la filosofia” (C. Castoriadis, La rivoluzione democratica…)
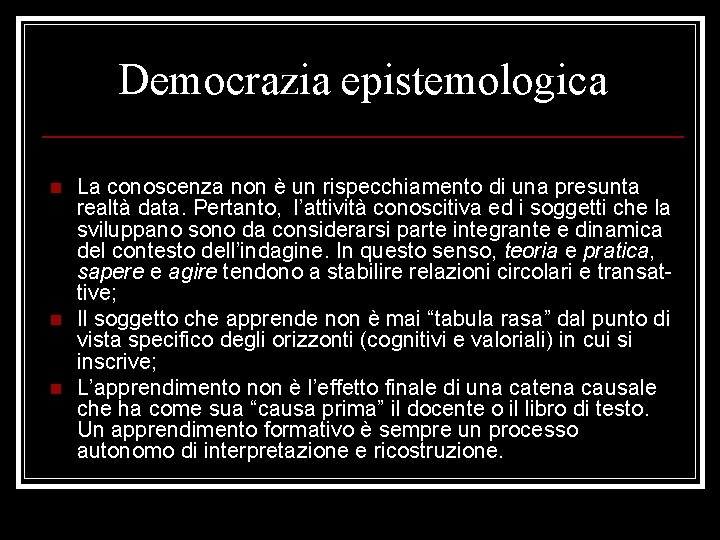
Democrazia epistemologica n n n La conoscenza non è un rispecchiamento di una presunta realtà data. Pertanto, l’attività conoscitiva ed i soggetti che la sviluppano sono da considerarsi parte integrante e dinamica del contesto dell’indagine. In questo senso, teoria e pratica, sapere e agire tendono a stabilire relazioni circolari e transattive; Il soggetto che apprende non è mai “tabula rasa” dal punto di vista specifico degli orizzonti (cognitivi e valoriali) in cui si inscrive; L’apprendimento non è l’effetto finale di una catena causale che ha come sua “causa prima” il docente o il libro di testo. Un apprendimento formativo è sempre un processo autonomo di interpretazione e ricostruzione.
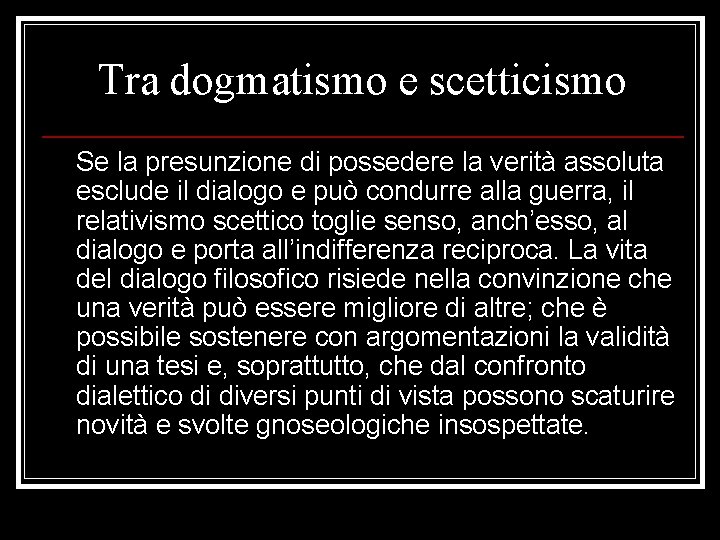
Tra dogmatismo e scetticismo Se la presunzione di possedere la verità assoluta esclude il dialogo e può condurre alla guerra, il relativismo scettico toglie senso, anch’esso, al dialogo e porta all’indifferenza reciproca. La vita del dialogo filosofico risiede nella convinzione che una verità può essere migliore di altre; che è possibile sostenere con argomentazioni la validità di una tesi e, soprattutto, che dal confronto dialettico di diversi punti di vista possono scaturire novità e svolte gnoseologiche insospettate.

Quali criteri di verità Sono le diverse comunità di parlanti, i contesti culturali e le pratiche discorsive a cui l’individuo prende parte che forniscono i criteri ed i vincoli a cui fare appello per legittimare o delegittimare le produzioni di pensiero e per formulare criteri di verità.
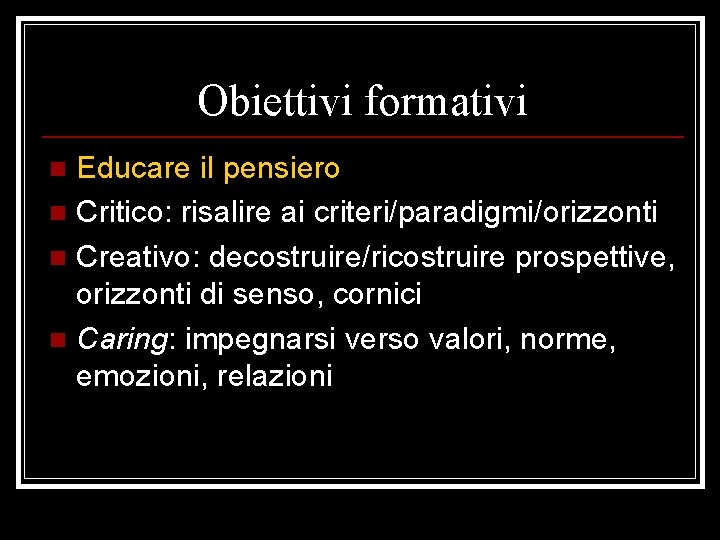
Obiettivi formativi Educare il pensiero n Critico: risalire ai criteri/paradigmi/orizzonti n Creativo: decostruire/ricostruire prospettive, orizzonti di senso, cornici n Caring: impegnarsi verso valori, norme, emozioni, relazioni n
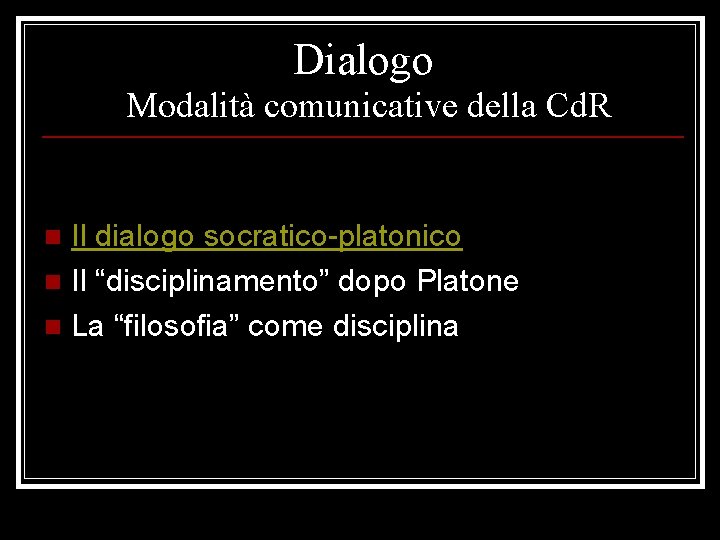
Dialogo Modalità comunicative della Cd. R Il dialogo socratico-platonico n Il “disciplinamento” dopo Platone n La “filosofia” come disciplina n
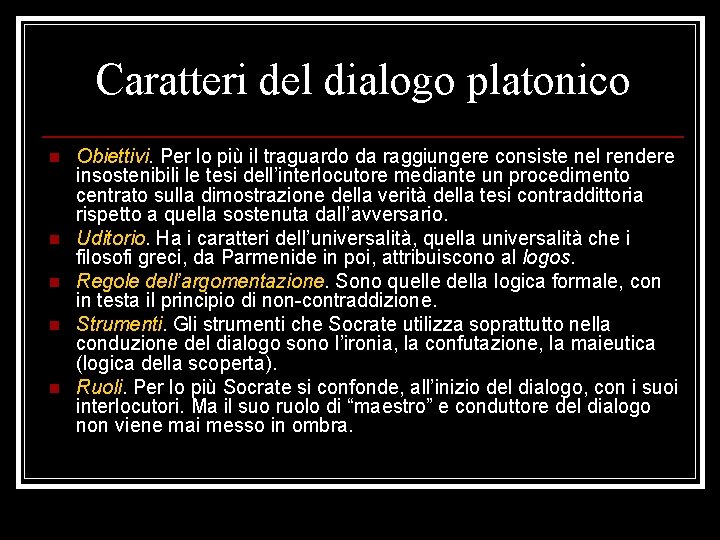
Caratteri del dialogo platonico n n n Obiettivi. Per lo più il traguardo da raggiungere consiste nel rendere insostenibili le tesi dell’interlocutore mediante un procedimento centrato sulla dimostrazione della verità della tesi contraddittoria rispetto a quella sostenuta dall’avversario. Uditorio. Ha i caratteri dell’universalità, quella universalità che i filosofi greci, da Parmenide in poi, attribuiscono al logos. Regole dell’argomentazione. Sono quelle della logica formale, con in testa il principio di non-contraddizione. Strumenti. Gli strumenti che Socrate utilizza soprattutto nella conduzione del dialogo sono l’ironia, la confutazione, la maieutica (logica della scoperta). Ruoli. Per lo più Socrate si confonde, all’inizio del dialogo, con i suoi interlocutori. Ma il suo ruolo di “maestro” e conduttore del dialogo non viene mai messo in ombra.
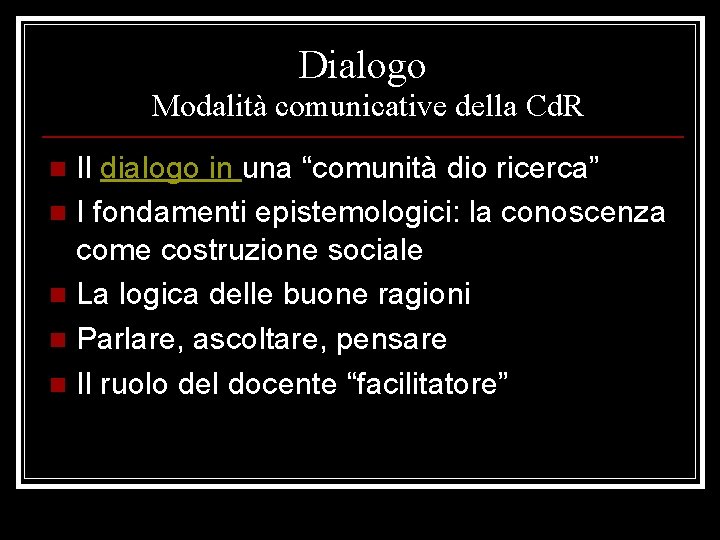
Dialogo Modalità comunicative della Cd. R Il dialogo in una “comunità dio ricerca” n I fondamenti epistemologici: la conoscenza come costruzione sociale n La logica delle buone ragioni n Parlare, ascoltare, pensare n Il ruolo del docente “facilitatore” n

Il dialogo nella Cd. R Facilitatore (ascolta, valorizza le differenze) n Uditorio reale (componenti emotive, relazionali, ecc. ) n Logica delle “buone ragioni” (informale) n Radicalizzazione del domandare (incluse tutte le premesse). n
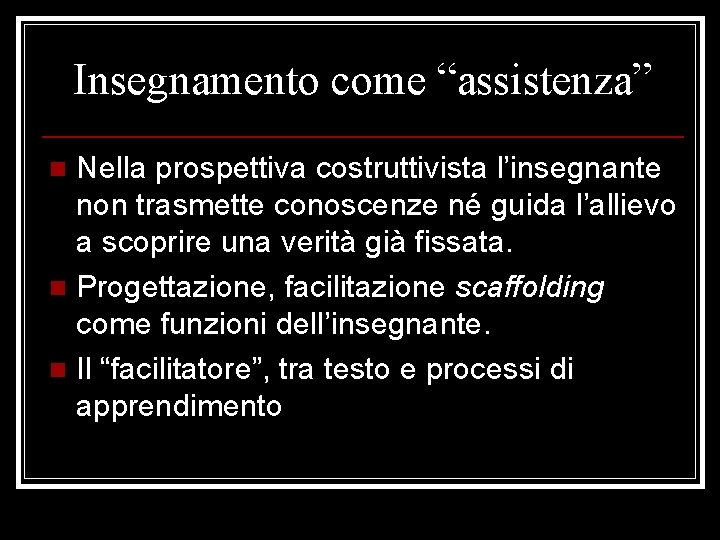
Insegnamento come “assistenza” Nella prospettiva costruttivista l’insegnante non trasmette conoscenze né guida l’allievo a scoprire una verità già fissata. n Progettazione, facilitazione scaffolding come funzioni dell’insegnante. n Il “facilitatore”, tra testo e processi di apprendimento n
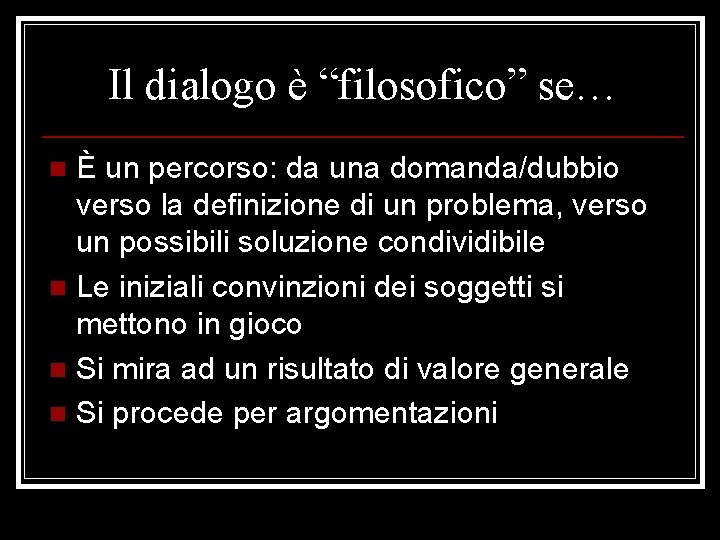
Il dialogo è “filosofico” se… È un percorso: da una domanda/dubbio verso la definizione di un problema, verso un possibili soluzione condividibile n Le iniziali convinzioni dei soggetti si mettono in gioco n Si mira ad un risultato di valore generale n Si procede per argomentazioni n
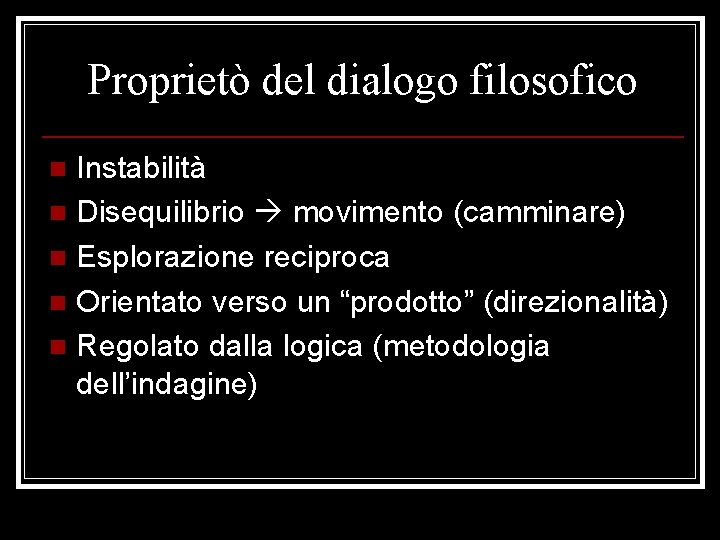
Proprietò del dialogo filosofico Instabilità n Disequilibrio movimento (camminare) n Esplorazione reciproca n Orientato verso un “prodotto” (direzionalità) n Regolato dalla logica (metodologia dell’indagine) n
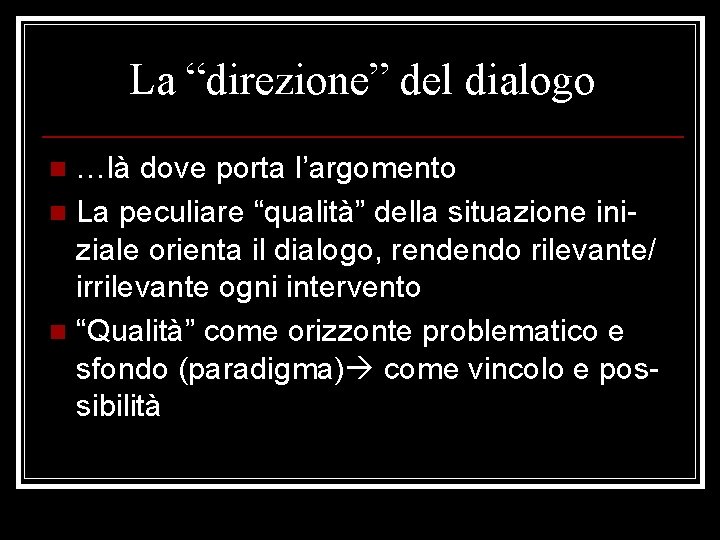
La “direzione” del dialogo …là dove porta l’argomento n La peculiare “qualità” della situazione iniziale orienta il dialogo, rendendo rilevante/ irrilevante ogni intervento n “Qualità” come orizzonte problematico e sfondo (paradigma) come vincolo e possibilità n