Breve storia della lingua italiana LOttocento e il

Breve storia della lingua italiana L’Ottocento e il Novecento Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 1

I temi della lezione • • • Napoleone Bonaparte Il purismo toscano Alessandro Manzoni La disunità d’Italia Graziadio Isaia Ascoli Giovanni Verga Alcuni letterati italiani tra Ottocento e Novecento Ricordi personali della letteratura italiana dell’ 800 La politica linguistica postunitaria Il burocratese italiano Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 2

Napoleone Bonaparte (1769 -1821) • Il prestigio della lingua francese aumenta. • Entrano così nell'italiano parole come progresso, pregiudizio, contratto sociale, cittadino, democrazia, patriota e altre, legate allo 'spirito del tempo' e divenute fondamentali nel nostro lessico ottonovecentesco. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 3

Napoleone Bonaparte (1769 -1821) • Nelle aree più vicine alla Francia (Piemonte, Lombardia), il francese diventa la lingua della conversazione nelle classi medio-alte, alternandosi in questa funzione al dialetto. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 4

Napoleone Bonaparte (1769 -1821) • Napoleone prende misure per imporre la centralità di una sola varietà linguistica, il toscano, le plus parfait dei dialetti d’Italia e stabilisce che in tutti gli atti pubblici e privati il toscano potrà essere usato a fianco del francese. • Ripristina l’Accademia della Crusca (1808), istituisce un premio per le migliori opere in lingua italiana ecc. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 5

Il purismo toscano • Tra i sostenitori del modello puristico toscano per l’italiano si distinguono, oltre che Napoleone, si distinguono le figure di padre Antonio Césari, padovano (1760 -1828) e Basilio Puoti, napoletano (1782 -1847). Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 6

Il purismo toscano • In tutti prevale comunque l'idea che ci sia stato, nel passato, un periodo aureo in cui la lingua italiana è stata perfetta, e che dopo di allora non ci sia stato altro che progressivo decadimento e corruzione. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 7

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • Alessandro Manzoni scrisse il più importante romanzo italiano dell’ 800: I promessi sposi (prima edizione del 1827, versione definitiva del 1840). • “Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume. . . ” Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 8

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • Si tratta di un romanzo storico ambientato nella Lombardia del 16281630 che ha per protagonisti i giovani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella il cui matrimonio viene impedito dal signorotto del loro paese, don Rodrigo, a causa di una futile scommessa col cugino Attilio. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 9

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • In seguito a un tentativo di rapimento della ragazza, i due fidanzati sono costretti a separarsi e a fuggire, andando incontro a una serie di disavventure (Lucia incontrerà la monaca di Monza, l'innominato, il cardinal Borromeo, mentre Renzo sarà coinvolto nei moti popolari a Milano il giorno di S. Martino del 1628 e dovrà rifugiarsi nel Bergamasco). Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 10

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • La peste del 1630 farà in modo che i due promessi si ritrovino nel lazzaretto di Milano e, in seguito alla morte del loro persecutore a causa dell'epidemia, potranno infine sposarsi e trasferirsi nel territorio di Bergamo. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 11
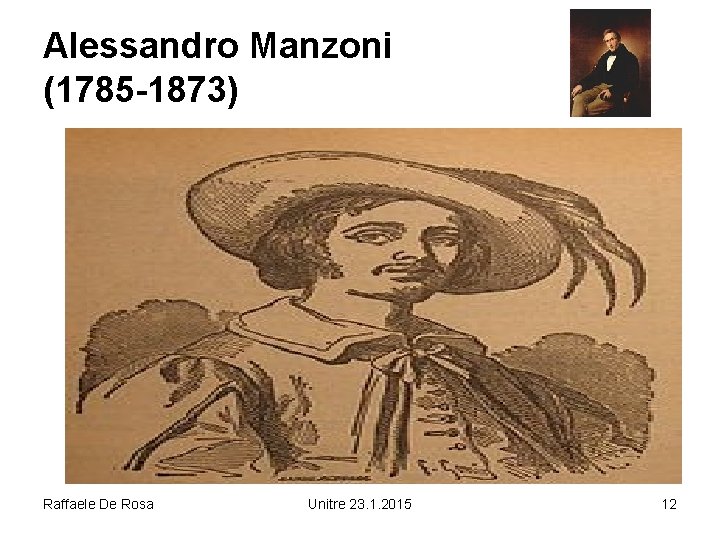
Alessandro Manzoni (1785 -1873) Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 12

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • Per Manzoni la letteratura e la lingua che la veicolava dovevano essere diffuse presso fasce ampie di popolazione, in particolare presso quegli strati borghesi che rappresentavano la nuova classe produttiva. • La separazione fra letterati e illetterati, fra scrittori e pubblico non aveva alcun senso: la lingua - diceva Manzoni - deve essere comune a chi scrive e a chi legge, a chi parla e a chi ascolta. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 13
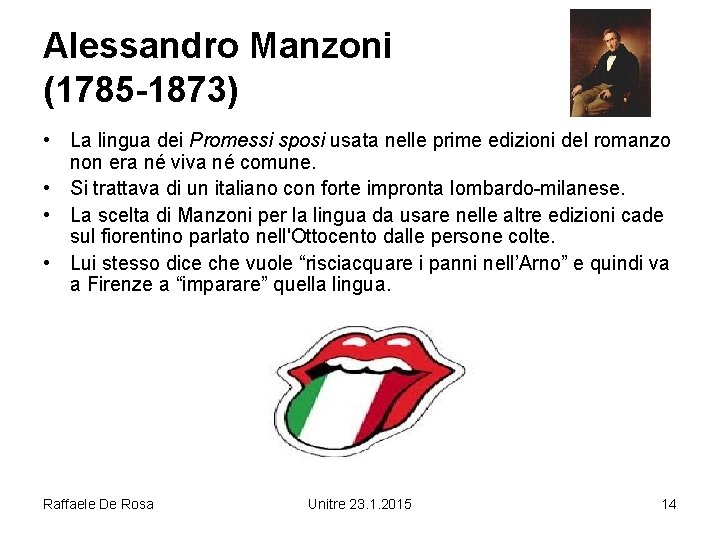
Alessandro Manzoni (1785 -1873) • La lingua dei Promessi sposi usata nelle prime edizioni del romanzo non era né viva né comune. • Si trattava di un italiano con forte impronta lombardo-milanese. • La scelta di Manzoni per la lingua da usare nelle altre edizioni cade sul fiorentino parlato nell'Ottocento dalle persone colte. • Lui stesso dice che vuole “risciacquare i panni nell’Arno” e quindi va a Firenze a “imparare” quella lingua. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 14

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • In questo modo Manzoni dà vita a un nuovo modello di lingua letteraria, vicino alle forme della comunicazione quotidiana e simile, per molti aspetti, all’italiano attuale. • Secondo Manzoni bisogna cercare una lingua che possa essere «il mezzo d'intendersi Italiani con Italiani» ; • Egli cerca di avvicinare tra loro la lingua scritta e quella parlata. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 15

Alessandro Manzoni (1785 -1873) • Manzoni ha l’obiettivo di diffondere in tutta Italia «la buona lingua e la buona pronunzia» e formula le seguenti proposte: – la redazione di un "vocabolario del linguaggio fiorentino vivente" da diffondere nelle scuole; – la redazione di vocabolari dialettali per apprendere l'italiano partendo dai vari dialetti; – l'invio di maestri toscani per tutta la penisola, a insegnare agli altri quella che per loro era la lingua madre; – l’invio di maestri non toscani a Firenze, per impararvi l'italiano. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 16
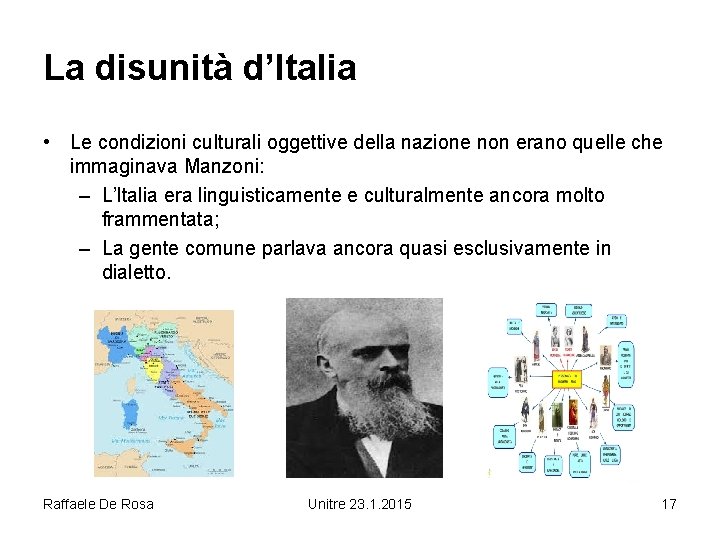
La disunità d’Italia • Le condizioni culturali oggettive della nazione non erano quelle che immaginava Manzoni: – L’ltalia era linguisticamente e culturalmente ancora molto frammentata; – La gente comune parlava ancora quasi esclusivamente in dialetto. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 17
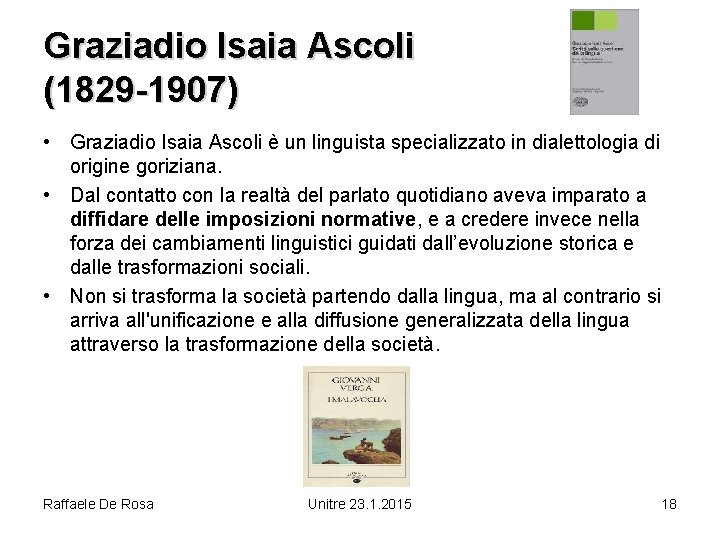
Graziadio Isaia Ascoli (1829 -1907) • Graziadio Isaia Ascoli è un linguista specializzato in dialettologia di origine goriziana. • Dal contatto con la realtà del parlato quotidiano aveva imparato a diffidare delle imposizioni normative, e a credere invece nella forza dei cambiamenti linguistici guidati dall’evoluzione storica e dalle trasformazioni sociali. • Non si trasforma la società partendo dalla lingua, ma al contrario si arriva all'unificazione e alla diffusione generalizzata della lingua attraverso la trasformazione della società. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 18

Graziadio Isaia Ascoli (1829 -1907) • Ascoli mette in rilievo il fatto che manca nella storia d'Italia una generale «comunità di pensiero» , cioè una vasta e continua circolazione della cultura. • Una lingua unitaria si avrà solo per evoluzione naturale, quando ci sarà una vita nazionale vera e propria, ricca di scambi, aperta al progresso civile, sensibile al progresso scientifico, immune dalla retorica. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 19
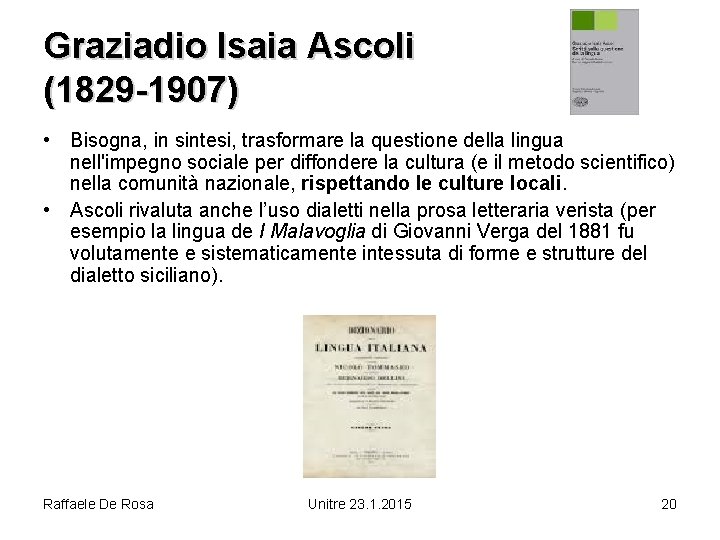
Graziadio Isaia Ascoli (1829 -1907) • Bisogna, in sintesi, trasformare la questione della lingua nell'impegno sociale per diffondere la cultura (e il metodo scientifico) nella comunità nazionale, rispettando le culture locali. • Ascoli rivaluta anche l’uso dialetti nella prosa letteraria verista (per esempio la lingua de I Malavoglia di Giovanni Verga del 1881 fu volutamente e sistematicamente intessuta di forme e strutture del dialetto siciliano). Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 20

Giovanni Verga (1840 -1922) • Padron 'Ntoni è il capofamiglia de I Malavoglia. Si esprime spesso attraverso proverbi e vecchi detti. Secondo lui "Gli uomini sono come le dita di una mano: il dito grosso fa da dito grosso e il dito piccolo fa da dito piccolo". Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 21

Alcuni letterati italiani tra Ottocento e Novecento • • • Ugo Foscolo (1778 -1827) Giacomo Leopardi (1798 -1835) Giosuè Carducci (1835 -1907) Antonio Fogazzaro (18421911) Giovanni Pascoli (1855 -1912) Emilio Salgari (1862 -1911) Grazia Deledda (1871 -1936) Luigi Pirandello (1867 -1936) Gabriele D’Annunzio (18631938) Giuseppe Ungaretti (18881970) Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 22

Ricordi personali della letteratura italiana dell’ 800 Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 23
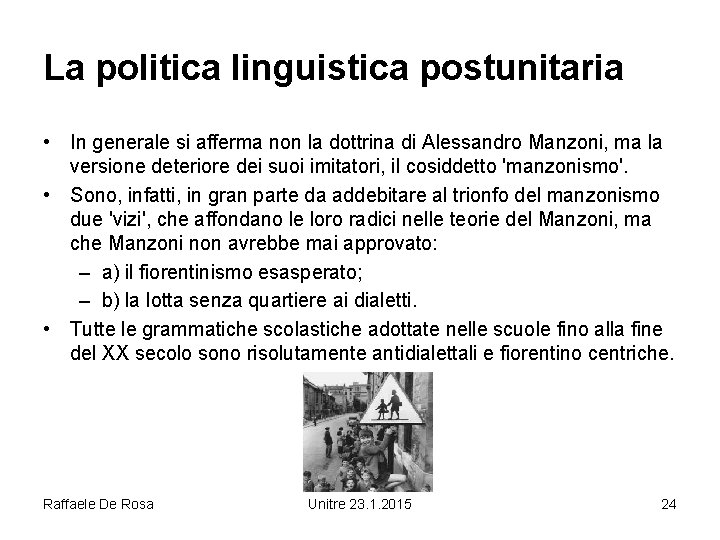
La politica linguistica postunitaria • In generale si afferma non la dottrina di Alessandro Manzoni, ma la versione deteriore dei suoi imitatori, il cosiddetto 'manzonismo'. • Sono, infatti, in gran parte da addebitare al trionfo del manzonismo due 'vizi', che affondano le loro radici nelle teorie del Manzoni, ma che Manzoni non avrebbe mai approvato: – a) il fiorentinismo esasperato; – b) la lotta senza quartiere ai dialetti. • Tutte le grammatiche scolastiche adottate nelle scuole fino alla fine del XX secolo sono risolutamente antidialettali e fiorentino centriche. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 24
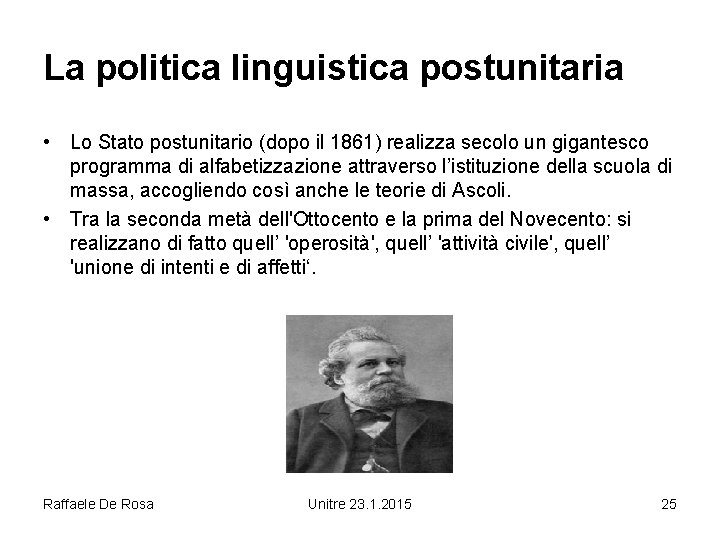
La politica linguistica postunitaria • Lo Stato postunitario (dopo il 1861) realizza secolo un gigantesco programma di alfabetizzazione attraverso l’istituzione della scuola di massa, accogliendo così anche le teorie di Ascoli. • Tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento: si realizzano di fatto quell’ 'operosità', quell’ 'attività civile', quell’ 'unione di intenti e di affetti‘. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 25

La politica linguistica postunitaria • L’uso comune dell’italiano si impone su vari livelli: – i dialetti si italianizzano; – si forma un italiano regionale parlato con vari tipi di pronuncia, lessico e grammatica (per es. le imitazioni dialettali di Enrico Brignano). Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 26

La politica linguistica postunitaria • Oltre alla scuola hanno agito in direzione dell'italofonia, una serie di fattori socio-economici che possiamo sinteticamente indicare: – a) il massiccio fenomeno delle migrazioni interne e verso l’estero (il salto linguistico si colloca di solito a livello dei figli degli immigrati, che hanno in genere una competenza solo passiva del dialetto d'origine e parlano solo italiano); Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 27

La politica linguistica postunitaria • b) l’apparato amministrativo centralizzato, con documenti in “burocratese”; • c) il servizio militare obbligatorio, che mette in rapporto tra loro soldati provenienti da regioni diverse; • d) la stampa e le trasmissioni di massa (cinema, radio, televisione), determinanti per l’espansione dell'italiano a scapito dei dialetti e la circolazione di innovazioni lessicali e linguistiche. Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 28

Il burocratese italiano Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 29

Il burocratese italiano Raffaele De Rosa Unitre 23. 1. 2015 30
- Slides: 30